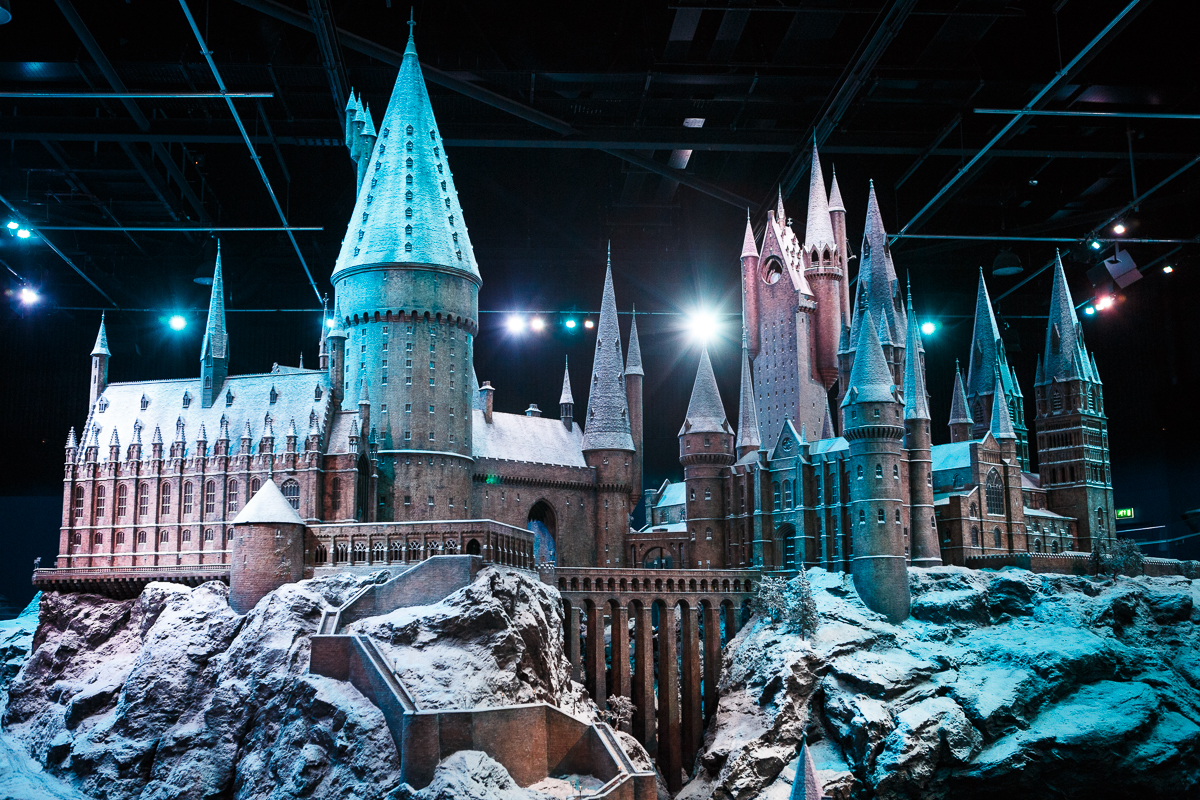Amo sentire l’odore delle persone, sentire la terra, la fatica, il sudore, osservare le rughe, quei solchi che raccontano davvero chi si è (Angela Iantosca)
Richard Gere, Nicolas Cage e Jessica Alba sono solo alcune delle star che Angela Iantosca ha conosciuto e intervistato durante la sua carriera, eppure nessuna di loro compare sulle foto incorniciate nello studio o tra gli scatti conservati sul cellulare. Sono altre le immagini che guarda di continuo e vuole ricordare: ritraggono i luoghi abbandonati in cui vivono i suoi “Bambini a metà – I figli della ‘ndrangheta” a cui ha dedicato l’ultimo libro.
Ha conosciuto e intervistato molte celebrità di Hollywood, eppure ha deciso di scrivere degli ultimi. Perché?
La mia passione è dare voce agli ultimi, amo sentire l’odore delle persone, sentire la terra, la fatica, il sudore, osservare le rughe, quei solchi che raccontano davvero chi si è.
Come si fa ad essere immersi per lavoro in realtà criminali e osservarle dal punto di vista dei più deboli come donne e bambini senza restarne risucchiati?
Ogni volta che mi immergo in quelle realtà abbandono ogni giudizio, mi limito a farmi attraversare da quelle vite così lontane dalle nostre e questo viaggio doloroso m’impedisce di vivere ignorandole. Non è semplice, ti risucchiano: sono storie violente e sanguinarie, fanno nascere lacrime, lacerano, ma quel dolore che provocano in me non è niente rispetto a ciò che loro hanno vissuto o stanno vivendo. Per questo la mia sofferenza deve essere messa al loro servizio e trasformata nelle parole che loro non hanno la forza di pronunciare.
Come si mantiene la fiducia nell’umanità, quando si vede di cosa sono capaci gli uomini?
Serve un forte equilibrio interiore per non perdere la speranza e non lasciarsi guidare dalla rabbia. Esiste una soluzione a portata di cuori: fare rete, camminare insieme, stringere il cerchio intorno a chi delinque, impedire che i bambini crescano come soldati senza emozioni, aiutare quelle donne a scappare da lì, far capire loro che un altro mondo esiste e che la verità non è quella dettata dalla ’ndrangheta.

Quanto è importante la fede?
La fede aiuta, fa sentire protetto, come da un mantello magico che ti rende invisibile e invulnerabile, dà forza perché tu hai qualcosa che loro non hanno: l’amore. Quando li osservo, chiusi nelle loro piccole vite che pensano di dominare, vedo gli schemi mentali, i riti e so che quella loro religione non è fede, ma strumento di dominio, ridicola fame di potere che dimentica una cosa fondamentale: siamo solo di passaggio su questa Terra. In preda ad un delirio di onnipotenza, non ci accorgiamo di perdere ogni giorno le cose più semplici, la bellezza di un sorriso e di un abbraccio.
Ha iniziato il percorso di fede in famiglia?
Sin da bambina i miei genitori mi hanno iniziata alla fede. Ho frequentato il catechismo, il sacerdote parlava di un Dio gioioso e mi piaceva andare in Chiesa e cantare nel coro. Mi sentivo felice, in pace, in armonia. Una sensazione di pienezza che cerco sempre, ogni giorno, da allora. Non potrò mai dimenticare il giorno della Prima Comunione: lo stomaco chiuso, la notte insonne. Credo sia stato il gesto più consapevole che ho compiuto nella mia vita. La nostra chiesa, San Pietro e Paolo, era piccolissima, una catapecchia con il tetto in lamiera, un rifugio, non una chiesa sfarzosa.
Ricorda un “cambio di rotta” nella sua spiritualità?
Quando papà si è ammalato di Alzheimer, a 19 anni, non capivo e mi sono arrabbiata… con Lui, prima di tutto. Sapevo che se mi fosse successo qualcosa mio padre – non una persona semplice, gelosissima e restrittiva – anche in capo al mondo ci sarebbe stato. Ed è stata questa la prima cosa a cui ho dovuto rinunciare, a quella colonna che ho visto sgretolarsi quel 31 dicembre del 1997, quando mia madre di ritorno dalla visita neurologica ha pronunciato quella parola, Alzheimer, con cui avevamo trovato una giustificazione alle stranezze degli ultimi anni di papà: le caffettiere dimenticate sul fuoco, i lacci delle scarpe non più annodati, noi figlie lasciate fuori da scuola, le strade sbagliate, la macchina parcheggiata chissà dove. È cominciato un calvario al quale ho deciso di non far partecipare Dio.
Se l’è presa con il Signore?
Non è stato un litigio vero e proprio: non gli ho urlato contro niente. L’ho solo lasciato andare via. Nel frattempo la vita si complicava terribilmente: la vendita della casa, le medicine che costavano troppo, i lavoretti presi per pagarmi i libri per l’Università… E in tutto questo non avevo tempo per Dio. Come non avevo tempo per provare amore verso papà. Avevo una rabbia dentro enorme. Non accettavo che non potesse più riconoscermi. Poi una sera, un giovedì di marzo 2003, dopo avergli preparato da mangiare mi ha chiesto: “Come va? Tutto bene?”. Ho detto di sì e dal giorno dopo non mi riconosceva più. Sono state quelle le sue ultime parole consapevoli. O almeno così credevo. Papà è morto 7 anni dopo. Intanto ho smesso di fargli la guerra e di colpevolizzarlo, ho deciso che qualcosa doveva cambiare: dovevo provare a comunicare con lui in qualche modo, con la musica, ballando abbracciati, tenendolo stretto, lavandolo. Sentivo il suo amore come non l’ho mai sentito da parte sua negli anni in cui era presente. Poi il giorno della sua morte ho smesso di pensare a quello che avrei voluto dirgli e ho ascoltato ciò che stava accadendo. Prima di spirare gli abbiamo detto che lo amavamo molto e lui ha sorriso. Da quel momento ho sentito che era su di noi, intorno a noi. Che ora era presente, come non lo era più stato negli ultimi anni. Da quel momento ho fatto pace con Dio.

Che ruolo ha giocato la fede nel processo di redenzione e salvezza dei piccoli che racconta nel suo libro?
La Chiesa in alcuni casi è estremamente presente ed utile… soprattutto in quei territori. Ha svolto un ruolo chiave per molti, come per Francesco Rigitano, ex ragazzo difficile oggi alla guida di una comunità a Marina di Gioiosa, nella Locride. Don Pino De Masi, referente di Libera, è fondamentale per i bambini della Piana di Gioia Tauro; suor Carolina, ex braccio destro di don Puglisi, accoglie nella sua comunità vicino San Luca alcuni ragazzi e don Panizza a Lamezia Terme ha dato vita ad una comunità partendo dai disabili.
C’è un bambino, tra quelli che ha incontrato, che le ha insegnato una lezione di vita indimenticabile?
La storia centrale è quella di Libero. Il ragazzo che per primo è stato inserito nel protocollo “Liberi di Scegliere” voluto dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, nella persona del dottor Di Bella. Libero appartiene ad una delle famiglie più sanguinarie della Calabria. Il padre è stato ucciso e i fratelli sono in carcere. Dopo aver commesso un atto vandalico viene assolto, per un anno viene inserito in una comunità al di fuori della Calabria per conoscere una realtà diversa dalla sua. Ne ho visto il cambiamento: gli occhi di chi è cresciuto tra bunker e violenza non sono più chiusi sulla realtà circostante, ma ora non più. Sa che c’è altro oltre la sua terra: Libero, come ho deciso di chiamarlo, ora è libero davvero.
SCRITTRICE DEGLI ULTIMI: Prima di “Bambini a metà – I figli della ‘ndrangheta” (Perrone) Angela Iantosca ha pubblicato il saggio “Onora la madre – storie di ’ndrangheta al femminile” (Rubbettino) e il racconto “L’urlo del Leone” all’interno della raccolta “Siria. Scatti e parole” (Miraggi Edizioni). Giornalista da 12 anni, scrive di donne coraggiose sul settimanale “F” e conduce reportage di cronaca per “La vita in diretta” su Rai Uno dopo i servizi per “L’aria che tira” su La7. Coordinatrice del mensile “Acqua&Sapone”, si occupa principalmente di tematiche sociali: “Essere giornalista – spiega – significa questo: diventare un megafono per aiutare chi è debole ad amplificare la propria voce. Non ho mai scritto e non intendo scrivere per riempire gli scaffali delle biblioteche. Di carta ce n’è già troppa! Scrivo perché qualcosa possa accadere nelle coscienze, perché non rimangano nell’ombra le storie, perché chi decide di uscire dalla malavita abbia poi una rete alla quale appoggiarsi, perché i ragazzi coltivino la speranza per il futuro e si rendano conto di essere i veri protagonisti”.
L’intervista è stata pubblicata sul settimanale “A sua immagine”, numero 106, 17 gennaio 2015